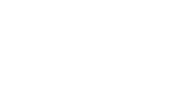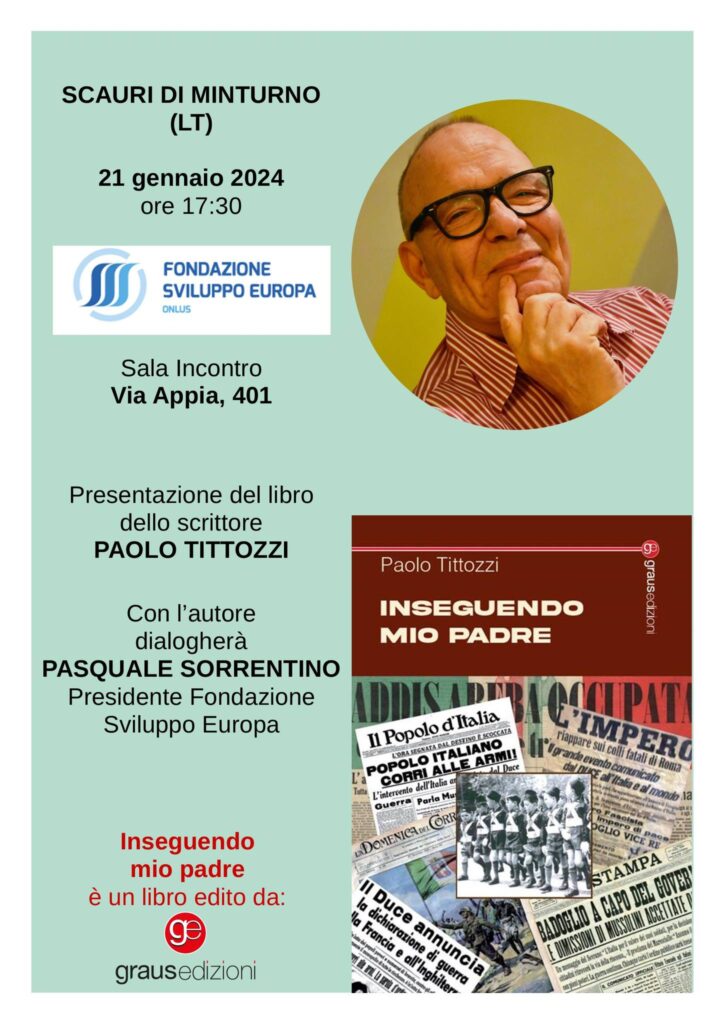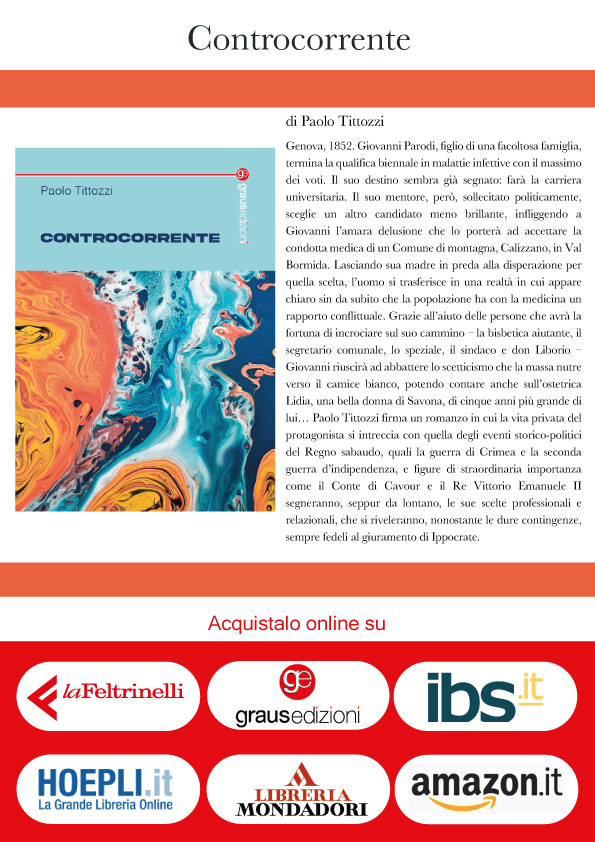Torino, la bella città, si mangia si beve e bene si sta! Questa filastrocca che i bambini siciliani calabresi e pugliesi recitavano alla fine degli anni Cinquanta ci dà la misura di quanto fosse attrattiva la città industriale per eccellenza.
Oggi, “Giornata del migrante italiano” desidero accendere una luce sul fenomeno delle migrazioni interne che rappresenta una delle conseguenze più rilevanti della crescita industriale del nostro Paese. Dal 1951 al 1960 circa due milioni di persone hanno abbandonato il Mezzogiorno per trasferirsi nelle città del nord e il boom economico, che crebbe in maniera vertiginosa tra il 1958 e il 1963, fu possibile anche grazie al poderoso aiuto di questo esercito di persone che arrivarono dalle campagne del Sud.
Questa massa di uomini soli che hanno viaggiato per anni nei “treni del sole”, propriamente non si possono neanche chiamare migranti, non avendo loro mai lasciato il suolo italiano. Il Sud era diventato il serbatoio di manodopera per il triangolo industriale. Gli effetti furono immediati: le campagne si spopolarono e le città del Nord si riempirono con evidenti problemi di sovraffollamento e insufficienza dei servizi. Dalla Calabria, dalla Sicilia, dalla Campania si partiva con una valigia di cartone e con in tasca l’indirizzo di un compaesano che ”forse” ti avrebbe potuto ospitare in attesa che tu trovassi un lavoro. Quasi un terzo di questi uomini erano analfabeti, la gran parte non era mai andata a scuola mentre altri dopo qualche mese avevano evaso l’obbligo scolastico che nessuno si era preoccupato di far rispettare, anche perché nel paesello natio questa menomazione non pesava, i punti di riferimento erano pochi e certi e di questo lusso se ne poteva fare a meno senza problemi.
Arrivato però nella grande città per il migrante meridionale e analfabeta tutto era diventato drammatico. L’indirizzo che aveva in tasca era per lui un pezzo di carta privo di significato, le strade erano migliaia e con targhe indecifrabili, i mezzi pubblici avevano dei numeri sconosciuti comunque, dopo tante peripezie, quando si riusciva ad incontrarsi con il proprio compaesano che viveva in qualche locanda infima o in soffitte fatiscenti perché i meridionali erano guardati con diffidenza, costui non solo gli diceva che non lo avrebbe potuto ospitare, ma gli confessava anche che trovare un lavoro in fabbrica per un analfabeta sarebbe stato del tutto impossibile. Però, per fortuna di quei migranti-non migranti analfabeti o semianalfabeti, in quegli stessi anni queste città stavano vivendo anche un disordinato il “boom edilizio” ovvero una selvaggia speculazione edilizia con la nascita di nuovi quartieri urbani per nulla regolati e lì trovarono lavoro passando da braccianti agricoli affamati a manovali sfruttati e sottopagati affrontando situazioni lavorative e abitative assai più precarie di quelle dell’operaio dell’industria e sperimentando sulla loro pelle una integrazione sociale assai più problematica.
“Torino, la bella città, si mangia si beve e bene si sta!” forse a questa filastrocca in fondo non credevano neanche i bambini.
In questi stessi anni ci fu un altro milione e mezzo di italiani varcarono la frontiera: ma di questa storia ne parleremo un’altra volta.